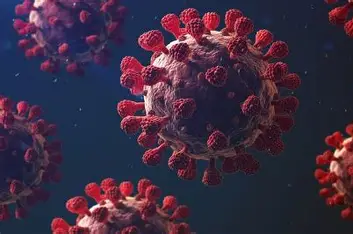
La Corte Costituzionale con sentenza del 24 luglio 2025, n. 124 definisce una quaestio iuris, da anni oggetto di dibattito tra gli operatori del settore.
La questione attiene agli organi muniti di giurisdizione nelle ipotesi in cui, oggetto della controversia, siano i contributi a fondo perduto erogati nel periodo dell’emergenza sanitaria.
Qualora ci si limitasse alla lettura dell’art. 2, D. Lgs. 546/92, rubricato “oggetto della giurisdizione tributaria” si potrebbe agevolmente ritenere che il contributo de quo, rientri nella giurisdizione tributaria, in quanto, la predetta norma, nell’alveo della giurisdizione tributaria vi fa rientrare “i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Il contributo potrebbe, prima facie, rientrare nel più ampio genus dei tributi.
È noto, tuttavia, che il predetto art. 2, non deve essere interpretato, limitatamente alla littera legis, ma occorre indagare la natura della prestazione.
Si pensi, ad esempio, ai contributi previdenziali i quali, pur rientrando nel genere “tributi” non costituiscono oggetto di giurisdizione tributaria, ma di giurisdizione ordinaria (in quanto assume rilevanza il rapporto sotteso, ovvero, quello tra datore di lavoro e lavoratore di natura privatistica).
Nel caso dell’ipotesi di contributi Covid, allora, non si deve tenere in considerazione il nomen iuris, ma la sostanza, nonché la finalità della prestazione.
Se è vero che non vi è una norma che definisca il “tributo” è ormai consolidata la definizione offerta dalla Corte Costituzionale che ha indicato i presupposti, affinché possa trattarsi di tributi (ex multiis, Corte Cost., n. 304 del 2013):
1)il depauperamento patrimoniale di una parte;
2) il soddisfacimento di un interesse fiscale;
3) il rapporto non sinallagmatico tra le parti.
I tributi, infatti, sono tali in quanto rappresentano una prestazione patrimoniale imposta dallo Stato o da altro ente pubblico, con conseguente depauperamento del patrimonio del soggetto passivo.
Effettuata tale premessa, appare opportuno ricostruire sinteticamente il percorso che ha condotto alla pronuncia della Corte.
Con ordinanza del 3 giugno 2024 (reg. ord. n. 143 del 2024), la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, sezione 2, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 102, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all’atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dei predetti articoli, per violazione dell’art. 102, Cost. (con assorbimento della censura di cui all’art. 3 Cost.) muovendo dall’assunto che la giurisdizione tributaria “deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto” (Corte Cost. n. 39 del 2010).
Ne consegue che l’attribuzione a detta giurisdizione di controversie non aventi a oggetto rapporti di natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali (art. 102 Cost.).
Il contributo a fondo perduto istituito dall’art. 1 del “decreto ristori”, come evidenziano i giudici costituzionali, non ha natura tributaria, in quanto è privo, del carattere di definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, perché viene in rilievo l’erogazione, da parte dello Stato, di una somma di denaro a operatori economici privati (Corte Cost. n. 80 del 2024).
Il contributo di cui trattasi non integra neanche un beneficio fiscale (es. credito di imposta), perché non consiste in una riduzione del carico tributario, ma trattasi di una misura di sostegno a carattere economico in favore di determinate categorie di soggetti che arricchiscono e non depauperano l’altrui patrimonio.
In definitiva, per i giudici della Corte, il contributo a fondo perduto non può essere considerato una prestazione di natura tributaria, presupposto idoneo a giustificare la giurisdizione tributaria.
Daniela Mendola, Professore a contratto di diritto tributario, Università degli Studi di Salerno

